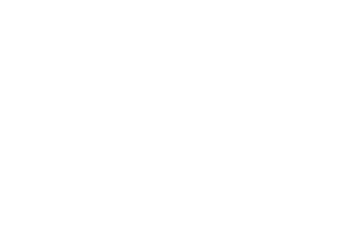Lavorare in rapporti di tensione 2:
L’indirizzamento e il paradosso del riconoscimento
«Come ogni progetto sociale, il progetto di riconoscimento di per sé, ma anche
i singoli progetti concreti di riconoscimento vanno intesi nei modi specifici in cui
si rapportano a sistemi di potere. Non appena il riconoscimento sociale diventa concreto come rivendicazione o progetto, esclude.» (Mecheril 2000)
Come descritto nel testo d’approfondimento del capitolo 1, una delle motivazioni storiche per la mediazione culturale è la rivendicazione dell’accessibilità delle arti come bene comune a tutti i membri di una società. Negli ultimi decenni, è aumentata la pressione sulle istituzioni culturali finanziate con fondi pubblici affinché producano risultati in termini di numero di visitatori e composizione plurale del pubblico. Parallelamente, è in aumento la concorrenza con altre offerte del settore del tempo libero e della formazione. Tali fattori sono tra l’altro all’origine del fatto che le istituzioni culturali – anche quelle per le quali l’ipotesi di una democratizzazione delle arti non è necessariamente prioritaria – sviluppano un → orientamento in funzione dei visitatori e cercano, tramite offerte di mediazione per destinatari specifici, di ampliare il proprio pubblico. Ci si rivolge così a gruppi sociali che non fanno parte del pubblico tradizionale delle istituzioni e per i quali si presuppone che necessitino di un invito attivo. Si tratta di parti della popolazione che dispongono di un → capitale culturale ed economico relativamente ridotto e che quindi, da una posizione privilegiata, sono considerate «svantaggiate» o «a basso livello d’istruzione».
relativamente ridotto e che quindi, da una posizione privilegiata, sono considerate «svantaggiate» o «a basso livello d’istruzione». (→ Mecheril 2000). Da un lato, almeno a prima vista, l’invito avviene nell’intento di creare o perlomeno dischiudere la possibilità della parità. D’altra parte, l’indirizzamento presuppone un’identificazione e quindi una determinazione dei destinatari come altri, appunto come non uguali. Le identificazioni effettuate non sono né casuali né neutrali, ma caratterizzate dalle prospettive e dagli interessi degli invitanti. Non hanno solo la funzione di produrre alterità, ma anche di confermare il proprio come norma da perseguire. Con la designazione di «a basso livello d’istruzione» per esempio si pone la questione della concezione di istruzione che consente di misurare il livello della stessa in determinate persone. Il termine è usato nel dibattito sull’utilizzazione della cultura e intende (solitamente implicitamente) la carenza d’affinità con il canone borghese riconosciuto d’istruzione.1 Il termine «a basso livello d’istruzione» è quindi impiegato come designazione d’alterità da coloro che partono dal presupposto che la propria istruzione sia adatta anche per gli altri. Da questo punto di vista, l’«uguaglianza» perseguita appare intendere, nel contesto di questo e di molti altri indirizzamenti, meno la parità quanto piuttosto il diritto (o l’obbligo?), di assimilarsi a coloro che esprimono l’invito. Nella discussione concernente l’accesso al mercato del lavoro il termine «a basso livello d’istruzione» intende la mancanza di una formazione certificata e di diplomi scolastici. Lo studioso della formazione Erich Ribolits avverte per contro che «formazione» non deve essere intesa come compatibilità con le esigenze del mercato del lavoro e propone di intendere invece con questo termine «l’abilitazione […] ad affermarsi contro i vincoli sistemici della società risultanti dagli attuali rapporti di potere». Le persone istruite in tal modo «si opporrebbero a un orientamento totalitario della vita in base alla massima performance nel lavoro e nei consumi» e «non considererebbero la natura solo come oggetto di sfruttamento e le altre persone solo come concorrenti» (→ Ribolits 2011). Da un lato, afferma Ribolits, in questa prospettiva gran parte della popolazione andrebbe considerata «a basso livello di istruzione». D’altra parte, questi atteggiamenti si troverebbero in disparati strati della popolazione e non presenterebbero alcun nesso causale né con elevati livelli di formazione accademica o professionale né con concezioni di cultura borghesi. Con un siffatto concetto di formazione si potrebbe eventualmente addirittura interpretare il sapere e il saper fare di persone con scarso capitale culturale ed economico (per es. una capacità così rafforzata di improvvisazione e sovversione) come caratteristiche di un’élite colta.
Mentre il concetto di «a basso livello di istruzione» è usato spesso per l’identificazione, ma mai esplicitamente per rivolgersi ai gruppi mirati, perché difficilmente qualcuno lo riterrebbe un giudizio positivo, questo non vale per la locuzione usata sempre più spesso, ma non per questo meno problematica, di «persone con background migratorio». Nella prima decade del 21° secolo (più precisamente: dall’attentato al World Trade Center a New York l’11 settembre 2001), la questione del posizionamento e dei principi guida delle istituzioni culturali nella → società migratoria è diventata centrale, come risulta dal gran numero di progetti, studi, dossier e conferenze.2 L’indirizzamento effettuato da attori della mediazione culturale – non da ultimo come reazione ai dettami di politica di sostegno –
a «persone con background migratorio» manca però completamente l’enorme pluralità e complessità delle costruzioni di identità nelle società d’immigrazione, perché si rivolge prevalentemente a gruppi ben precisi, bollati etnicamente e civicamente come «altri». Concretamente: con le offerte di mediazione culturale non si tratta di coinvolgere nella vita artistica → espatriati benestanti, ma per l’appunto persone identificate come aventi «un basso livello d’istruzione» e «un background migratorio». Mecheril e altre autrici e autori evidenziano che questa forma d’identificazione corrisponde a una culturalizzazione di problematiche strutturali e sociali. Gli effetti di diseguaglianza sociale, giuridica e politica causati dalle strutture della → società maggioritaria non sono tematizzate; invece il principale modello esplicativo diventa proprio la differenza culturale degli stessi invitati precedentemente stabilita, per la loro assenza dalle istituzioni. Nessuna meraviglia, quindi, che presso i destinatari si desti una crescente resistenza all’indirizzamento come «Mimimi» (Mysorekar 2007). Nell’autunno del 2011, la → Kulturinitative Tirol ha promosso ad esempio un workshop sul tema «antirazzismo e lavoro culturale»:3
«Nel frattempo, nei contesti ‹critici›,ovvero antirazzisti, c’è un maggiore o minore consenso in merito al fatto che i dibattiti pubblici sulla migrazione dovrebbero spostarsi dai migranti ai problemi sociali: si tratta, cioè, di parlare non di migranti «poco acculturati», bensì della miseria e delle strutture razziste del sistema formativo; non di migranti che approfittano del nostro sistema sociale, bensì di meccanismi a effetto emarginativo ecc. Inoltre, il dibattito sulla migrazione si è spostato molto sui migranti provenienti da paesi islamici: se fino a qualche anno fa si parlava ancora di migranti con genitori o nonni turchi, oggi si tratta di migranti musulmane_i.»
Domande a partire dal presupposto che il lavoro culturale crea discorso:
- Qual è il contributo del libero lavoro culturale al dibattito sulla migrazione?
- Come si può compiere un lavoro culturale antirazzista, senza affrontare l’attuale dibattito sulla migrazione?
- È possibile per es. presentare domande di sussidio senza diventare parte di questo dibattito?
- È possibile rinunciare alla_al «migrante»? Oppure: lavoro antirazzista senza attribuzioni identitarie.
- Come si affrontano nel lavoro culturale libero i razzismi all’interno e all’esterno del proprio lavoro?
- Il lavoro antirazzista ha a che fare con la distribuzione delle risorse?
- In base a quali criteri si identifica il razzismo?
- In base a quali criteri si identifica l’antirazzismo?»
1 Uno fra tanti esempi d’attualità quando è stato scritto questo testo: «Nel frattempo, alcuni conservatori di lingua tedesca propongono corsi di formazione e perfezionamento in mediazione musicale come preparazione per disparati settori d’intervento per gruppi mirati da giovani ad anziani, da ‹indigeni› a ‹postmigranti› e da ‹colti› a ‹poco acculturati›.» In: KM. Das Monatsmagazin von Kulturmanagement, Network Kultur und Management im Dialog. N.67 Maggio 2012, p.15. Download al sito → http://www.kulturmanagement.net/downloads/magazin/km1205.pdf [25.8.2012] vedi documentazione MFV0211.pdf
2 Alcuni esempi: convegni: «inter.kultur.pädagogik.» Berlino 2003; «Interkulturelle Bildung –
Ein Weg zur Integration?» Bonn 2007; «Migration in Museums: Narratives of Diversity in Europe» Berlino 2008; «Stadt – Museum – Migration» Dortmund 2009; «MigrantInnen im Museum» Linz 2009; «Interkultur. Kunstpädagogik Remixed» Norimberga 2012. Ricerca/sviluppo: «Creating Belonging», Zürcher Hochschule der Künste, promosso dal FNS 2008–09; «Migration Design. Codes, Identitäten, Integrationen», Zürcher Hochschule der Künste, promosso dalla CTI 2008 – 2010; «Museums as Places for Intercultural Dialogue», progetto UE 2007–09; «Der Kunstcode – Kunstschulen im Interkulturellen Dialog», Bundesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen e.V. (BJKE), promosso dal Bundesministerium für Bildung und Forschung 2005 – 2008, «Museum und Migration: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund als Zielgruppe von Museen», Linzer Institut für qualitative Analysen (LIquA), su mandato della città di Linz e del Land Oberösterreich, Abteilung Soziales und Institut für Kunst und Volkskultur 2009 – 2010. Pubblicazioni e dossier tematici: Handreichung zum Schweizerischen Museumstag 2010; KulturKontakt Austria
(a c. d.) (2008): hautnah. Beispiele partizipativer Kunstvermittlung im interkulturellen Dialog, Vienna;Vera Allmanritter, Klaus Siebenhaar (a c. d.) (2010): Kultur mit allen! Wie öffentliche deutsche Kultureinrichtungen Migranten als Publikum gewinnen, Berlino: B&S Siebenhaar; Zentrum für Audience Development der FU Berlin (2009): Migranten als Publika von öffentlichen deutschen Kulturinstitutionen – Der aktuelle Status Quo aus Sicht der Angebotsseite; → http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/v/zad/news/zadstudie.html [16.4.2012].
3 Il workshop è stato diretto da Vlatka Frketic.
4 Con «appartenenti alla maggioranza» si intendono in questo testo cittadine e cittadini svizzeri indipendentemente dalla regione linguistica.
5 «Respingere le nozioni di eterno femminino, di anima negra, di carattere giudaico non significa negare che vi siano, oggi Ebrei, Negri e donne: questa negazione non ha per gli interessati un significato di libertà ma una fuga dall’autenticità.» (Beauvoir 1968, p. 9)
Bibliografia e link
Il testo si basa in parte sui seguenti contributi già pubblicati: Altri riferimenti bibliografici:- Almanritter, Vera; Siebenhaar, Klaus (a c. d.): Kultur mit allen! Wie öffentliche deutsche Kultureinrichtungen Migranten als Publikum gewinnen, Berlino: B & S Siebenhaar, 2010
- Arts Council, England: A practical Guide to working with Arts Ambassadors, Londra: Arts Council, 2003 [12.10.2012]; → MFV0209.pdf
- Castro Varela, Maria do Mar: Interkulturelle Vielfalt, Wahrnehmung und Selbstreflexion aus psychologischer Sicht (s. d.) [12.10.2012]; → MFV0210.pdf
- Gülec, Ayse et al.: Kunstvermittlung 1: Arbeit mit dem Publikum, Öffnung der Institution, Berlino / Zurigo: Diaphanes 2009
- Kilomba, Grada: «Wo kommst du her?», in: Heinrich Böll Stiftung, Dossier Schwarze Community in Deutschland (s. d.) [16.8.2012]; → MFV0208.pdf
- Mecheril, Paul: Anerkennung des Anderen als Leitperspektive Interkultureller Pädagogik? Perspektiven und Paradoxien, manoscritto della relazione al workshop interculturale dell’IDA-NRW 2000 [14.10.2012]; → MFV0201.pdf
- Mysorekar, Sheila: «Guess my Genes – Von Mischlingen, MiMiMis und Multiracials», in: Kien Nghi Ha et al. (a c. d.): re/visionen – Postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland, Münster: Unrast, 2007, pp. 161 – 170
- Ribolits, Erich: «Wer bitte ist hier bildungsfern? Warum das Offensichtliche zugleich das Falsche ist», in: HLZ, Zeitschrift der GEW Hessen, n. 9 / 10, 2011 [12.10.2012]; → MFV0202.pdf
- Spivak, Gayatri Chakravorty: «Can the Subaltern Speak?», in: Nelson, C.; Grossberg L. (a c. d.), Marxism and the Interpretation of Culture, Basingstoke: Macmillan, 1988, pp. 271 – 313
- Terkessidis, Mark: «Im Migrationshintergrund», in: der freitag 14.1.2011 [15.2.2013]; → MFV0206.pdf
- Wimmer, Constanze: «Kammermusik-Collage oder Babykonzert – von den vielfältigen Wegen der Musikvermittlung», in: KM. Das Monatsmagazin von Kulturmanagement Network. Kultur und Management im Dialog, n. 67, maggio 2012, p. 15 [25.8.2012]; → MFV0211.pdf
- Winter Sayilir, Sara: «‹Wo kommst du her?› – ‹Aus Mutti›. Antirassismustraining für Europa», in: WOZ Die Wochenzeitung, n. 31, 14. agosto 2011; → MFV0207.pdf